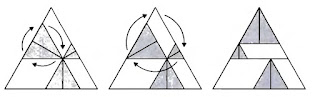Ho voluto prendere spunto, in modo abbastanza particolare, dal primo pezzo di tema citato, quello dei viaggi, per potervi parlare di qualcosa di singolare che avviene nel mondo degli atomi e delle particelle: l’effetto Auger.
Infatti scopriremo un “viaggio forzato” degli elettroni negli atomi sottoposti ad alcune condizioni particolari.
Diciamo sin da subito che il suddetto effetto ha un ruolo estremamente rilevante nell’ambito della spettroscopia.
Cos’è la spettroscopia?
In parole povere la spettroscopia è lo studio dell’interazione tra materia e radiazione ed è diventata lo strumento più comune per studiare in modo rigoroso i materiali.
Evolvendo dalla dispersione prismatica della luce visibile, la spettroscopia moderna si fonda sull’interazione di fasci irradiati sui materiali.
Entro la metà del XX secolo, divenne ovvio che la composizione chimica delle superfici e delle interfacce nelle dimensioni atomiche determina svariate proprietà dei materiali.
Per esempio, la corrosione e l’ossidazione, usura e attrito e le proprietà elettroniche dipendono fortemente dalla microchimica della superficie e dell’interfaccia.
Si innescò dunque una crescente domanda per l’analisi nella scala dello strato atomico.
Ciò portò a un rapido sviluppo dei metodi dell’analisi delle superfici basati sulla spettroscopia a ioni ed elettroni.
La spettroscopia ad elettroni Auger (abbreviata AES) fu la primissima tecnica usata per l’analisi delle superfici dei solidi, seguita dalla spettroscopia fotoelettronica a raggi X (abbreviata XPS).
Affinché possiate comprendere in pieno cosa sia l’effetto Auger è necessario però che io compia un breve excursus sull’effetto fotoelettrico.
Una superficie (solitamente) metallica in alto vuoto, investita da una radiazione di frequenza sufficientemente elevata, emette elettroni.
Questo è l’effetto fotoelettrico.
L’effetto fotoelettrico venne osservato per la prima volta da Heinrich Hertz nel 1887.
Il vuoto è necessario affinché gli elettroni non collidano con un’atmosfera di molecole troppo densa.
Ci sono 3 osservazioni fondamentali (dovute essenzialmente agli esperimenti compiuti da Philipp Lenard nel 1902) da compiere in merito a tale fenomeno:
1) l’effetto ha luogo solo se la frequenza della radiazione incidente supera un certo valore di soglia ν0. Tale soglia fotoelettrica dipende dal metallo usato. L’emissione degli elettroni avviene istantaneamente a seguito dell’irraggiamento.
2) Gli elettroni escono dal metallo con un’energia cinetica che va da 0 a un certo valore massimo TM. Questo valore è direttamente proporzionale alla differenza tra la frequenza incidente ν e la frequenza di soglia ν₀ caratteristica del materiale. La costante di proporzionalità è la stessa costante h trovata da Planck per interpretare lo spettro del corpo nero (se volete saperne di più leggete qua):
3) Il numero di elettroni emesso per unità di tempo e di superficie (ossia la corrente elettronica) è proporzionale all’intensità della radiazione incidente (a parità) di frequenza, mentre l’energia degli elettroni emessi risulta indipendente da tale intensità.
L’interpretazione classica non riesce assolutamente a spiegare questo fenomeno.
Questo perché dal punto di vista dell’elettromagnetismo classico (che descriveva la maggior parte dei fenomeni noti sino al 1900) l’onda elettromagnetica trasmette energia in modo continuo.
Invece per interpretare correttamente il fenomeno serve il concetto di quanto, introdotto da Planck nel 1900.
Il mitico Albert Einstein, durante il suo “annus mirabilis”, cioè il 1905, ha proprio elaborato un’interpretazione dell’effetto fotoelettrico fondata sul quanto.
Ironia della sorte è che tale studio (un po’ meno noto al grande pubblico rispetto alla sua teoria della relatività, prima ristretta, poi generale) gli valse il Nobel per la Fisica nel 1921, mentre per la relatività non gli fu assegnato alcun premio!
Per Einstein la radiazione, nel processo di assorbimento, si comporta come se fosse composta da particelle, dette fotoni (termine reso popolare dal chimico Gilbert Newton Lewis nel 1926), con energia pari a:
dove ν è la frequenza del fotone.
Il flusso (cioè il numero) di fotoni è ovviamente proporzionale all’intensità dell’onda, per considerazioni energetiche.
Un elettrone viene emesso interagendo con un singolo fotone.
Per poter capire cosa sia l’effetto Auger ci serve anche introdurre la struttura elettronica di un materiale (per semplicità assumiamo sempre che sia un metallo).
Quella che segue è un’immagine che ben la rappresenta in modo generico.
Gli elettroni di core sono chiamati in tal modo perché si trovano negli orbitali o livelli atomici ad energia più bassa, il che corrisponde ad essere più vicini al nucleo (core) e più legati all’atomo.
Indichiamo con la generica lettera E l’energia degli elettroni all’interno del metallo.
Possiamo poi definire uno 0 che corrisponde all’energia di vuoto (nella figura il vacuum level), ossia l’energia di elettroni che sono fermi (a riposo), appena fuori dalla superficie metallica. Al di sotto di tale energia avremo i vari livelli energetici.
Il livello di vuoto rappresenta l’ultimo livello corrispondente ad uno stato legato, ovvero tutti gli stati elettronici al di sotto del suddetto sono stati legati, cioè, in altre parole, l’elettrone è legato al materiale.
I livelli energetici al di sopra del livello di vuoto sono infatti corrispondenti ad elettroni che sono liberi di lasciare il materiale.
Pertanto gli elettroni fotoemessi sono elettroni che hanno livelli energetici al di sopra del livello di vuoto.
Se immaginiamo un elettrone al di sopra di tale livello, la differenza di energia tra il livello considerato e il livello di vuoto denota l’energia cinetica dell’elettrone che si sta allontanando indefinitamente dal materiale.
Se guardate bene, nel mezzo della figura c’è una linea tratteggiata. Beh questa è molto importante e va a designare il cosiddetto livello energetico di Fermi EF.
Ora allo zero assoluto (0 kelvin) avremo sostanzialmente che ciò che sta al di sotto del livello di Fermi sono livelli energetici occupati da elettroni, mentre andando al di sopra della suddetta linea troveremo tutti stati energetici vuoti.
Se però assumiamo una temperatura elevata, per esempio 1000 K, c’è una probabilità piccola (ma non nulla!) che, per eccitazione termica, qualche elettrone riesca a giungere sino al livello di vuoto.
Questi sono proprio gli elettroni che, avendo sufficiente energia, riescono a scappare dal potenziale attrattivo degli ioni del metallo e uscire dalla lamina creando una corrente termoionica.
Il discorso appena compiuto non è campato in aria a caso ma dipende da uno specifico strumento matematico che viene chiamato distribuzione di Fermi-Dirac.
Se ricordate, avevamo brevemente parlato del teorema spin-statistica in un post (cliccate qui).
Vi basti ora sapere (dato che i dettagli vanno ben oltre lo scopo puramente divulgativo del presente post) che quella di Fermi-Dirac è la statistica che governa le particelle chiamate fermioni (famiglia di cui l’elettrone fa appunto parte), mentre la statistica che regola i bosoni è detta di Bose-Einstein.
Ma nell’immagine di prima c’è da constatare la presenza di un ulteriore importante fattore: la funzione lavoro (o lavoro di estrazione) Φ.
È facile intuire che (assumendo E = 0 come livello di vuoto) essa è equivalente alla differenza E - EF, cioè alla distanza che sussiste tra il livello di vuoto e quello di Fermi.
La funzione Φ rappresenta dunque la minima barriera che gli elettroni devono superare per poter uscire dal materiale ed essere liberi di allontanarsi da esso.
Per quasi tutti i materiali essa è stimata dell’ordine di 4-5 elettronvolt.
Dovrebbe essere adesso chiaro che se l’energia di un singolo fotone è inferiore a questa quantità, esso non può estrarre alcun elettrone.
In tal modo viene compresa la soglia fotoelettrica a cui si faceva riferimento prima.
Inoltre è immediatamente spiegato il perché l’emissione avviene subito pure a intensità basse della radiazione incidente.
Infatti istantaneamente alcuni elettroni entrano in collisione con alcuni fotoni.
Anche l’osservazione 2) data all’inizio del post viene giustificata, giacché l’energia cinetica massima con cui l’elettrone esce è pari alla differenza tra l’energia del fotone incidente e la funzione lavoro.
In simboli la formula proposta da Einstein era:
La frequenza di soglia viene quindi interpretata come la frequenza minima che deve avere la radiazione affinché l’energia di un fotone sia almeno pari all’energia necessaria per estrarre un elettrone.
Gli elettroni escono con energie minori della massima in quanto perdono energia, dopo aver assorbito il fotone, dentro il solido, prima di uscire da esso.
L’analisi di tale distribuzione delle energie degli elettroni uscenti fornisce oggi un importante strumento per studiare la dinamica degli elettroni nei cristalli.
Infine, il numero di elettroni emessi è proporzionale al numero di fotoni incidenti, ovvero all’intensità dell’onda incidente, poiché tale è la probabilità che ha un elettrone di assorbire un fotone e venire liberato.
Questo numero è naturalmente indipendente dall’energia di ciascun fotone, cioè dalla frequenza della radiazione, mentre l’energia degli elettroni uscenti è indipendente dal numero di fotoni, ossia dall’intensità dell’onda incidente.
Siamo finalmente pronti per entrare nel vivo della narrazione.